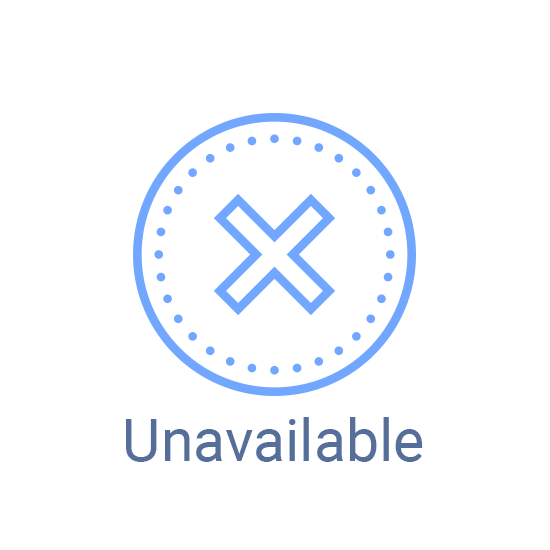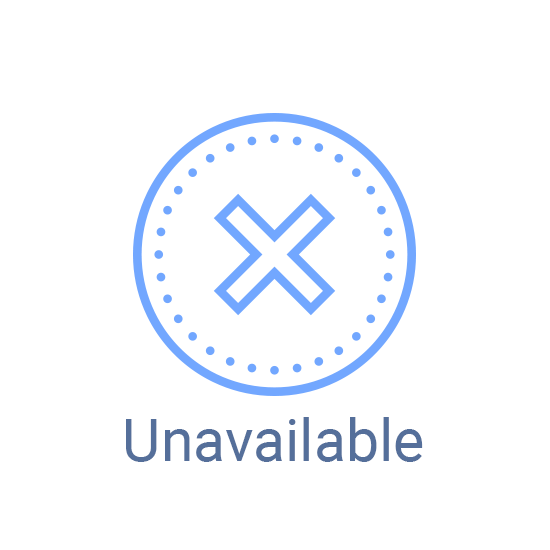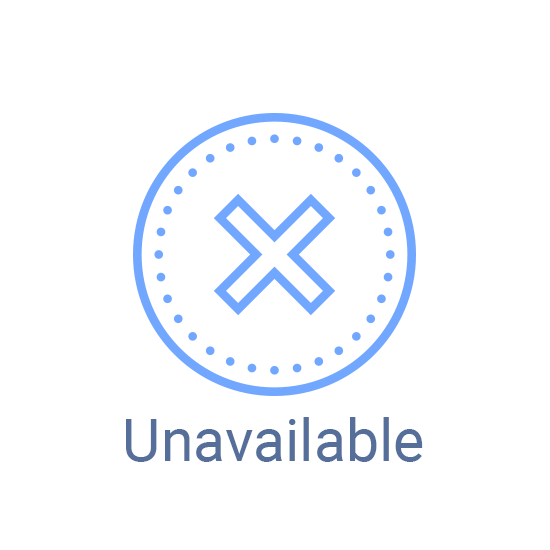LA METAMORFOSI DEI DIRITTI UMANI NELL’UE
(estratto dal volume “La transizione totalitaria” ed. La Vela)
Il compito delle Corti nazionali ed internazionali è principalmente quello di assicurare il rispetto dei diritti sanciti dalle norme fondamentali degli Stati, dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali.
Una funzione di controllo che, a seconda della funzione attribuita alla Corte/Tribunale, si esplica non solo nei confronti dei cittadini, ma anche delle Istituzioni e, in particolare, del potere legislativo e del potere esecutivo, rispetto ai quali il potere giudiziario, nella sua funzione di contrappeso, assume il delicato compito di ristabilire i limiti profanati, riconducendo le norme violative dei diritti fondamentali nell’alveo della legalità ed assicurandosi che la loro applicazione non comporti la violazione delle tutele sancite dalle Carte Costituzionali e dai Trattati, al cui rispetto il legislatore, prima di ogni altro, è tenuto.
Forse il dato più sconvolgente della progressiva demolizione del complesso dei diritti fondamentali, come tratto caratterizzante della gestione pandemica comune a quasi tutti gli Stati occidentali, è l’altrettanto comune avallo della profanazione di quei diritti da parte delle Corti che avevano il sacro compito di tutelarli.
Lo strumento utilizzato in quasi tutte le democrazie occidentali per giustificare la sostanziale negazione dei diritti primari dell’essere umano è una tecnica argomentativa di derivazione giurisprudenziale, creata con la pretesa necessità di risolvere ipotetici conflitti tra istanze giuridiche confliggenti: il bilanciamento.
Le affermazioni perentorie ed inequivocabili contenute nelle Carte Costituzionali sui diritti fondamentali dell’uomo sono state sin da subito vittima di una lenta, ma progressiva e certosina opera di reinterpretazione, che ha inevitabilmente portato alla sostanziale negazione dei valori espressi nei precetti costituzionali, privandoli di qualsiasi dignità.
La fuorviante idea che i diritti umani possano entrare in conflitto tra loro e che debbano, quindi, essere “ponderati” dallo Stato ha costituito il presupposto indefettibile grazie al quale è stato possibile attuare un radicale svuotamento delle libertà e dei principi di cui le Costituzioni dovevano essere portatrici.
L’emergenza ha solo fornito il pretesto per dare il colpo finale ad una struttura già profondamente minata nelle sue fondamenta, un colpo che ha determinato il crollo delle Costituzioni, a dispetto della loro “rigidità”.
Lo svuotamento semantico dei precetti costituzionali ed il preteso bilanciamento tra diritti che mai, per la loro natura, potrebbero entrare in conflitto tra loro hanno consentito l’abdicazione dello Stato di diritto verso una forma di totalitarismo fuori controllo.
Non è un caso che nella Carta fondamentale italiana non esista una norma che contempli la necessità di un contemperamento tra diritti o tra diritti e doveri inderogabili e che la disciplini.
Nei dibattiti dell’Assemblea costituente è spiegato, in modo non travisabile, la scelta delle parole “riconosce e garantisce” in riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo; essa riflette la precisa volontà di affermare solennemente che quei diritti, che costituiscono le comuni fondamenta delle più risalenti Costituzioni delle democrazie occidentali, appartengono all’essere umano per nascita e non perché concessi (o negati) da una norma.
Appartiene, oggi più che mai ai cittadini, il sacro compito di pretendere e rivendicare l’inviolabilità di quei diritti e di quelle libertà.